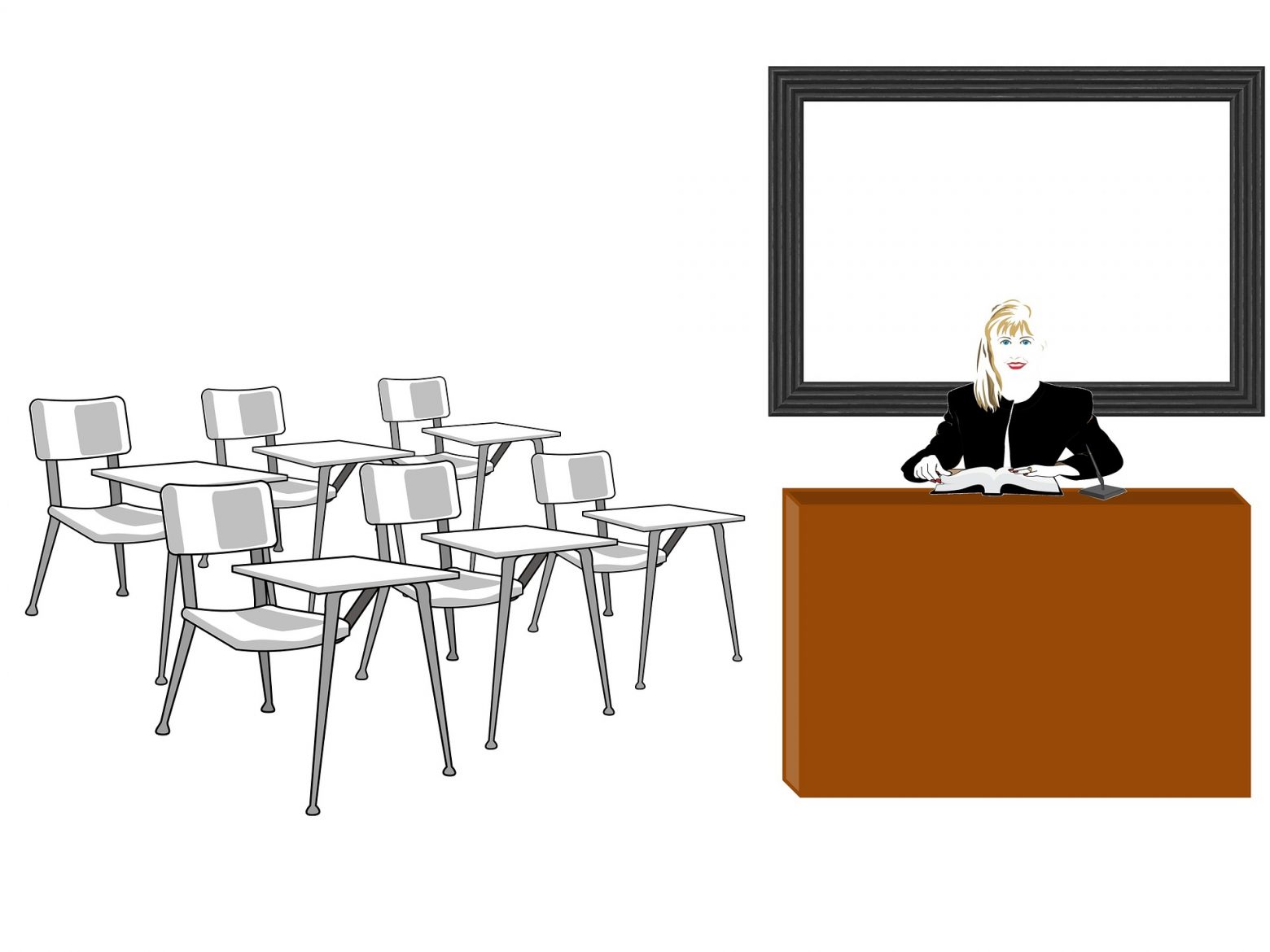Non ho visto la puntata di Report dedicata al vaccino contro il papilloma virus. Non voglio quindi valutare, nel merito, la trasmissione perché non ho elementi. Però, vista l’ennesima polemica che è nata attorno a questi temi – con la presa di distanza del ministro della Salute, l’impegno del virologo Burioni a “smontare” pezzo per pezzo quanto è stato affermato, la mole di condivisioni e contestazioni sui social – mi ronza in testa una domanda: perché quella sui vaccini sta diventando la “madre” di tutte le battaglie? Mi ronza in testa in quanto appartengo a quella generazioni che ha visto su compagni di scuola e coetanei i segni di malattie, come la polio, oggi ormai debellate. Per noi, le vaccinazioni sono state una potente arma a tutela della salute collettiva. Tutto, naturalmente, deve essere attentamente valutato (e l’informazione dei tecnici così come l’attenzione mediatica hanno un importante compito), ma faccio comunque fatica a comprendere questo furore, dal sapore quasi iconoclasta, scatenatosi contro le vaccinazioni.
Latest Posts
Buoni docenti per una Buona scuola (Lavoce.info)

Oggi il sito Lavoce.info ha pubblicato il mio commento all’intervento di Daniele Checchi e Maria De Paola sul nuovo sistema di assunzione e formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria. Ecco il testo pubblicato:
Nuovo modello per le assunzioni
Nel loro intervento pubblicato l’11 aprile sul nuovo sistema di assunzione e formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria, Daniele Checchi e Maria De Paola hanno espresso un giudizio sostanzialmente positivo, accanto al quale non manca comunque la critica ad alcuni specifici aspetti che possono rappresentarne punti di debolezza e quindi infirmare la positività dei risultati.
Prima di dimostrare l’infondatezza delle critiche, ricordo che la riforma rappresenta un vero cambio di paradigma. Ormai da decenni si diventava insegnanti – con modalità cambiate più volte – tramite esperienze dirette sul campo (insegnamenti per supplenza) ed esperienze formative presso le università (Ssis, Tfa, corsi abilitanti, Pas); conseguita l’abilitazione, c’era poi da superare uno dei rari ed erratici concorsi per l’assunzione in ruolo, oppure attendere l’assunzione diretta dalle graduatorie in lento scorrimento. Un sistema che ha causato lunghi e defatiganti precariati, la caccia ai punteggi più che alle competenze, la disaffezione delle persone più brillanti, senza dimenticare gli effetti della presenza nelle scuole di insegnanti ancora non ben formati e i costi economici a carico degli aspiranti docenti.
Il nuovo modello inverte l’ordine: prima un concorso per merito, a cadenza biennale, che selezionerà coloro che hanno la migliore preparazione disciplinare e un buon orientamento metodologico e psico-pedagogico; poi un percorso triennale, retribuito, di formazione alle competenze professionali e tirocinio (Fit) riservato ai vincitori del concorso e cogestito da università e scuole. Chi supererà positivamente il percorso Fit sarà assunto a tempo indeterminato come docente.
Nessun nuovo precariato
Una preoccupazione di Checchi e De Paola è che il concorso possa generare un numero di vincitori eccedente il fabbisogno reale di docenti. È forse sfuggito loro che non sarà messo a concorso alcun posto di insegnante che non corrisponda a un posto che si renderà vacante e disponibile al termine del periodo di formazione dei vincitori del concorso e che non ci saranno altri vincitori oltre quelli in numero pari ai posti messi a concorso. Non si alimenterà, quindi, nuovo precariato e, soprattutto, non ci saranno gli abilitati senza cattedra, che hanno rappresentato, incolpevoli, una sorta di incubatore di frustrazione e di precariato.
Molta dell’efficacia del sistema dipenderà dal rigore del lavoro valutativo delle commissioni, chiamate a giudicare soprattutto competenze professionali maturate nel triennio dai vincitori di concorso. Le commissioni saranno costituite da personale della scuola e del mondo accademico, per superare l’ingiustificata separazione di funzioni che ha contraddistinto fino ad ora la formazione iniziale e il reclutamento dei docenti: all’università la formazione e alla scuola la selezione, senza una solida condivisione degli obiettivi formativi e professionali da raggiungere. A questa nuova collaborazione strutturata e paritetica tra scuola e università spetterà anche la responsabilità di intercettare, per tempo, coloro i quali non dimostrassero attitudini e competenze adeguate alla funzione docente.
Come ogni riforma profonda, anche questa dovrà affrontare una fase transitoria che terrà conto della varietà dei docenti precari, generati dalla stratificazione di scelte pregresse e disorganiche. Il decreto legislativo tiene dunque conto di coloro che sono inseriti nelle graduatorie poste a esaurimento nel 2007, dei vincitori e idonei del concorso 2016, nonché dei già abilitati all’insegnamento e di coloro che, pur non essendo abilitati, insegnano da anni. In alcune regioni e discipline queste categorie sono già esaurite o in esaurimento (tanto che sono chiamati a insegnare anche neolaureati), in altre contengono ancora migliaia di persone. Per loro non sono previste sanatorie, bensì uno specifico percorso valutativo e formativo, differenziato in base alle esperienze già maturate e ai diversi titoli conseguiti, che consentirà nel tempo, a chi lo supererà, di essere assunto in ruolo su quote riservate di posti. Tutte le assunzioni saranno effettuate esclusivamente sulle disponibilità dell’organico attuale, frutto del turn-over o della trasformazione di posti dell’organico di fatto (insegnamenti ora coperti da precari) in organico di diritto. Non avverrà dunque alcuna “infornata”. Allo stesso tempo, per non privarsi dell’apporto dei laureati più giovani e motivati, ogni concorso, sin dal primo del 2018, riserverà loro una quota di posti, che crescerà progressivamente nel tempo, via via che la fase transitoria si andrà esaurendo nelle varie regioni e classi di concorso.
Merito, formazione, ricerca educativa integrata alla quotidianità della scuola, valutazione e programmazione sono i principi direttivi della riforma che è, innegabilmente, organica: ad essi sono parimenti ispirati il nuovo regime ordinario e quello transitorio, con l’obiettivo di assicurare buoni docenti per una buona scuola.
Manuela Ghizzoni, Parlamentare Pd e ricercatrice universitaria
Reclutamento prof, con la riforma formazione e selezione connesse per garantire merito e qualità

Ecco il testo di un mio articolo pubblicato in data odierna da Scuola 24:
Non c’è dubbio: la buona scuola si fa a partire da buoni docenti. E come formare insegnanti competenti e selezionare i candidati migliori per il lavoro nelle scuole? Con l’approvazione del decreto legislativo sulla formazione iniziale e sulle modalità di assunzione dei docenti della scuola secondaria (medie e superiori) arriva una risposta al quesito. Il nuovo sistema ha alcuni innegabili pregi, che possono dissipare i dubbi esposti da Daniele Checchi su questo giornale (“Reclutamento prof, si continua a preferire la quantità alla qualità ” di cui trovate copia in pdf in fondo a questo articolo).
Nei confronti degli studenti universitari che pensano oggi all’insegnamento come alla loro futura professione (in ambito umanistico resta la scelta prioritaria, al 32%), la politica ha la responsabilità di tracciare un percorso chiaro, stabile, ordinario, che consenta loro di operare scelte consapevoli, tanto rispetto all’iter formativo quanto a quella della disponibilità di posti. In altre parole, l’avvio alla professione dovrà essere orientato dalla motivazione, dalla competenza e dalla certezza del percorso. Come? Cambiando paradigma rispetto al sistema attuale, con due scelte “forti”: la prima è legare in modo indissolubile la fase della formazione a quella della selezione, fino ad oggi separate e quindi responsabili della frustrazione di quanti, pur abilitati alla professione (a loro spese), non sono riusciti ad entrare stabilmente nella scuola perché eccedenti rispetto alle necessità dell’organico; la seconda è programmare il numero degli ingressi nella scuola degli aspiranti docenti già a partire dalla formazione iniziale, in base ad un criterio più stringente del presunto fabbisogno, utilizzato fino ad oggi per i percorsi abilitanti.
La prima scelta si attua disponendo che gli aspiranti docenti sostengano un concorso orientato prevalentemente ad accertare le conoscenze e competenze disciplinari, successivamente al quale i soli vincitori siano avviati ad un triennio retribuito di formazione sul campo, tirocinio nelle scuole e inserimento progressivo nella funzione docente anche attraverso l’assolvimento, sotto la guida di tutor, di supplenze brevi nel secondo anno e, in quello successivo, di una supplenza annuale. Questa previsione, peraltro, contribuirà a ridurre il fenomeno del precariato a livelli finalmente fisiologici rispetto alle esigenze della scuola poiché, nel tempo, per coprire gli insegnamenti vacanti si farà sempre meno ricorso a supplenti. Nel triennio di formazione, le competenze specifiche della professione acquisite quali, ad esempio, quelle pedagogiche, relazionali, docimologiche, organizzative, tecnologiche saranno sottoposte a valutazioni intermedie e conclusiva: se positive, l’aspirante docente entrerà stabilmente nella scuola, senza necessità dell’anno di prova.
La programmazione degli accessi sarà invece garantita mettendo a concorso – con cadenza biennale – i soli posti che si renderanno “vacanti e disponibili” (cioè saranno liberi ed occupabili), nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui si svolgeranno le prove concorsuali, vale a dire a conclusione del triennio di formazione.
I vantaggi di tali scelte saranno quelli di poter immettere in ruolo docenti relativamente giovani, selezionati tra i più preparati nei saperi disciplinari, poi formati e valutati nelle competenze e attitudini professionali (in un lasso di tempo adeguato e con metodologie avanzate), senza che i neo-docenti abbiamo dovuto “sfinirsi” in estenuanti graduatorie, in condizione di precariato. Non si formeranno nuove liste di attesa inesauribili, non saranno frustrate le aspirazioni di lavorare nella scuola di coloro i quali sono stati valutati come idonei a farlo.
Già nel prossimo anno sarà bandito il primo concorso di accesso al nuovo sistema per una quota dei posti che si renderanno vacanti e disponibili dal 2021-22, a conclusione della formazione triennale. I posti restanti sono invece riservati alle procedure valutative riservate ad un articolato e ponderato regime transitorio, ispirato ai medesimi principi del regime ordinario – merito, formazione, valutazione e programmazione – e destinato a circoscritte platee di docenti precari: oltre a quelli presenti nelle graduatorie ad esaurimento (Gae) e quelli inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2016 (Gm 2016), disposti dalla legge 107, si aggiungono i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e coloro i quali, pur non abilitati, matureranno, nel tempo, 3 anni di docenza. La quota di posti destinata al nuovo sistema crescerà progressivamente ad ogni bando concorsuale, fino all’esaurimento delle attuali graduatorie e platee di precari.
La fase transitoria è necessaria per chiudere definitivamente con il pregresso e, al contempo, per dare risposte coordinate ed eque a chi ha già intrapreso la professione di insegnante, valorizzandone i titoli abilitativi e l’esperienza professionale maturata. Non si prevede, comunque, alcuna “onda anomala”, poiché i posti da coprire saranno quelli che si renderanno liberi per effetto del turn over o per trasformazione in organico “di diritto” di posti ora nell’organico “di fatto”, cioè posti già esistenti e necessari al funzionamento della scuola ma coperti da un docente precario perché giuridicamente non assimilabili all’organico che va occupato da personale di ruolo. Non si prevede nemmeno un “ingresso agevolato”, poiché sarà immesso in ruolo solo chi avrà superato appositi percorsi valutativi e, ove necessario, avrà completato la sua formazione professionale.
Le prove e i percorsi non saranno “laschi”, bensì differenziati sulla base delle diverse esperienze e titoli degli interessati, che potranno contare su specifiche riserve di posti per le varie categorie ma, al netto degli accessi da Gae e Gm 2016, non vi saranno automatismi di ingresso.
Il nuovo sistema è frutto di un attento esame delle esperienze pregresse di formazione iniziale, con particolare riferimento agli aspetti positivi dei percorsi abilitanti, e delle modalità di selezione, senza trascurare gli esiti dell’ultimo concorso a cattedre, al fine di dare organicità ad un asse portante di ogni buona scuola, come certificano tutte le indagini nazionali e internazionali: avere buoni docenti.
Ecco il pdf dell’articolo di Daniele Cecchi
Daniele Cecchi
Edilizia scolastica, 13mila gli interventi finanziati

Nel pomeriggio odierno la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli ha risposto al Question Time alla Camera a una interrogazione sul tema degli investimenti per la riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica presentata da un gruppo di parlamentari Pd, prima firmataria Maria Coscia, che ho avuto il compito di illustrare. Nella sua risposta la ministra ha confermato che la sicurezza di chi studia e lavora nelle nostre scuole rimane una priorità assoluta del Governo Gentiloni come lo era dei precedenti Esecutivi. Il complessivo piano del Governo ha consentito di finanziare oltre 13mila interventi, il cui stato di attuazione è costantemente monitorato e reso pubblico dal Ministero sul suo sito ufficiale con un sistema informativo che ha ricevuto il plauso dell’Europa come buona pratica. In particolare, alla ministra abbiamo chiesto notizie sullo stato di attuazione e avanzamento dei “Piano Bei”, ovvero il corposo mutuo finanziato dalla Banca europea degli investimenti, contratto a totale carico dello Stato e a disposizione degli Enti locali per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare sede di istituti scolastici. Valeria Fedeli ha confermato che con il primo piano Bei 2015, di un valore complessivo di 905 milioni avviato nel 2016, sono stati autorizzati 1.215 interventi, di questi ne risultano a oggi, dopo un anno, conclusi 721. A dicembre 2016, inoltre, sono stati autorizzati, con un decreto ministeriale, ulteriori 300 interventi, incentrati sul residuo di mutuo 2015, pari a circa 200 milioni di euro, che saranno avviati nel corso di questa estate. Infine, proprio in questi giorni la ministra ha firmato il decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui per il 2016: questo consentirà l’avvio, sempre questa estate, di ulteriori 200 interventi per un importo di 238 milioni di euro. Si tratta di uno sforzo molto rilevante, diffuso sul territorio, che muove dall’unica volontà di tutelare la sicurezza dei ragazzi che frequentano la scuola e del personale che ci lavora”.
Non da soli, per affrontare il periodo finale della nostra vita

Venerdì mattina ho partecipato al convegno organizzato dalla https://fadoi.org/ FADOI e AMICA http://www.infoamica.it/ su “La coscienza del fine vita in sanità” e l’Aula di Montecitorio è stata impegnata, martedì e mercoledì scorsi, nella discussione dei primi emendamenti al testo sul consenso informato e sulle disposizioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, il cosiddetto Biotestamento. Una coincidenza, dato che il convegno è stato fissato da molti mesi (peraltro sollecitato dalla presentazione romana – esattamente un anno fa – del film The perfect circle, di Claudia Tosi http://www.theperfectcirclefilm.com/wordpress/ , che sarebbe riduttivo definire come un film sulle cure palliative nel fine vita) ma è ben vero che l’argomento è, ormai, di consuetudine quotidiana: si pensi che son ben 16 le proposte di legge di iniziativa di deputati discusse e confluite nel testo base sul biotestamento). L’espressione “fine vita” non coincide, come si potrebbe fraintendere nel dibattito pubblico, con il caso drammatico di chi, a causa di una malattia mortale e dolorosa, invoca la fine o, caso altrettanto estremo, di chi in assenza di coscienza propria – per trauma o malattia – è mantenuto in vita con trattamenti sanitari contro la propria volontà precedentemente espressa; essa riguarda, più complessivamente, il periodo finale di una vita, che può durare anche anni, condizionato da un trauma grave o da una malattia con progressivo aggravamento ed esito infausto. Un periodo di estrema fragilità, più o meno lungo, che dolore fisico, paura per il proprio destino e timore dell’abbandono rischiano di trasformare in disperazione pura. Eppure, c’è speranza anche nel fine vita, dove è possibile non soffrire, grazie alle cure palliative, si possono compiere scelte importanti e libere, basate sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di volontà, e si è accompagnati, dai familiari e da ambienti sanitari in modo da non essere soli. Perché questo accada, occorre una forte, affidabile e reciprocamente accogliente relazione tra il paziente e l’équipe sanitaria, che non escluda i familiari, solido argine alla paura dell’abbandono. Che, in altre parole, è la chiave per ottemperare al diritto alla salvaguardia della vita, alla salute e alla propria libertà e autodeterminazione. Di questi temi, eticamente sensibili e complessi, si è parlato al convegno, che ha preso avvio con l’intervento della collega Donata Lenzi, relatrice del provvedimento sul biotestamento (della quale consiglio la lettura dell’intervento in discussione generale a Montecitorio http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0758&tipo=stenografico#sed0758.stenografico.tit00050.sub00010.int00020). Gli organizzatori del convegno sono stati medici ed infermieri: una scelta che testimonia della sensibilità del nostro personale sanitario e “rassicura” i possibili, futuri malati sulla solidità della relazione paziente ed équipe sanitaria
Un concorso e un triennio formativo per i nuovi docenti

Un cambio di paradigma, una svolta talmente sostanziale da imporre di prendersi il tempo necessario per esaurire la situazione pregressa e avviare in maniera ordinata la nuova fase. Il Governo ha approvato in via definitiva il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo degli insegnanti della scuola secondaria (medie e superiori, per intenderci), attuativo della delega della legge 107, accogliendo le proposte formulate dalla Commissione Cultura (ero relatrice del provvedimento in Commissione) tese a chiarire, in particolare, le diverse fasi del nuovo percorso e a introdurre modifiche sostanziali al regime transitorio, maturate nel corso della fase di ascolto di enti, associazioni, esperti, organizzazioni sindacali. Con il nuovo percorso, un laureato magistrale che deciderà di dedicarsi all’insegnamento dovrà prima vincere un concorso pubblico nazionale e, poi, affrontare un triennio retribuito di formazione sul campo, tirocinio nelle scuole e inserimento progressivo nella funzione docente, durante il quale acquisirà le competenze (quali, ad esempio, quelle pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, tecnologiche) specifiche della professione. Una volta superate le prove intermedie e quella finale del percorso, l’aspirante docente sarà automaticamente immesso in ruolo senza necessità dell’anno di prova e, soprattutto, senza aver dovuto svolgere attività di insegnamento in condizione di precariato. Già nel prossimo anno sarà bandito il primo concorso, per una quota dei posti che si renderanno vacanti e disponibili dal 2021-22 (poiché la formazione è triennale), ma il nuovo sistema entrerà a regime progressivamente, per disporre una vera, articolata fase di transizione, che si dipanerà per diversi anni al fine di chiudere con il pregresso e, al contempo, di dare risposte coordinate ed eque a chi ha già intrapreso la professione di insegnante, valorizzandone i titoli abilitativi all’insegnamento e l’esperienza professionale maturata. Sarà comunque immesso in ruolo solo chi avrà superato appositi percorsi valutativi – differenziati sulla base delle differenti esperienze e titoli degli interessati – e, ove necessario, avrà completato la sua formazione professionale. Certo, era impossibile accogliere tutte le sollecitazioni pervenute, in particolare dalla ancor vasta e differenziata platea dei docenti precari, ma si è lavorato per contemperare le istanze di chi vuole intraprendere nel futuro la professione docente, così come quelle di chi, attraverso le tante modalità previste nei sistemi che si sono succeduti nel tempo, ha acquisito titoli abilitativi che non possono andare dispersi. Il nuovo sistema si pone l’ambizioso obiettivo di evitare il riprodursi di nuove sacche di precariato, di formare specificatamente alla professione docente e migliorare, quindi, la qualità complessiva dell’offerta didattica per i giovani e le loro famiglie”.
In ricordo del sisma dell’Aquila, ma anche misure per il sisma dell’Emilia

Impossibile oggi, non pensare ai terremoti: il nostro e quello degli altri. Nella notte a L’Aquila, sono state ricordate le 309 vittime del sisma di 8 anni fa. Nel corso della giornata di ieri, poi, il Senato ha approvato, in via definitiva, il testo del decreto sul sisma del Centro Italia, che contiene alcune norme importanti anche per il “nostro” terremoto del 2012, inserite nel passaggio alla Camera con l’approvazione di nostri emendamenti. Si tratta, per tutelare le piccole imprese, di poter pagare direttamente le imprese subappaltatrici, nel caso in cui l’azienda appaltatrice sia sottoposta a concordato; di poter locare gli immobili danneggiati dal sisma già ristrutturati anche a nuclei familiari non terremotati, visto che questo fabbisogno è molto diminuito negli anni; infine, per le Amministrazioni, di poter recuperare contributi corrisposti e non dovuti per l’assistenza alla popolazione. Tre terremoti molto diversi, che uniscono le rispettive comunità con un filo rosso di solidarietà, sostegno reciproco e testimonianza. Terremoti come questi lasciano ferite difficilmente sanabili, ma al netto di dolore, paura, pazienza, fatica, determinazione e resilienza, la rinascita e la ricostruzione sono sempre possibili. Coraggio!