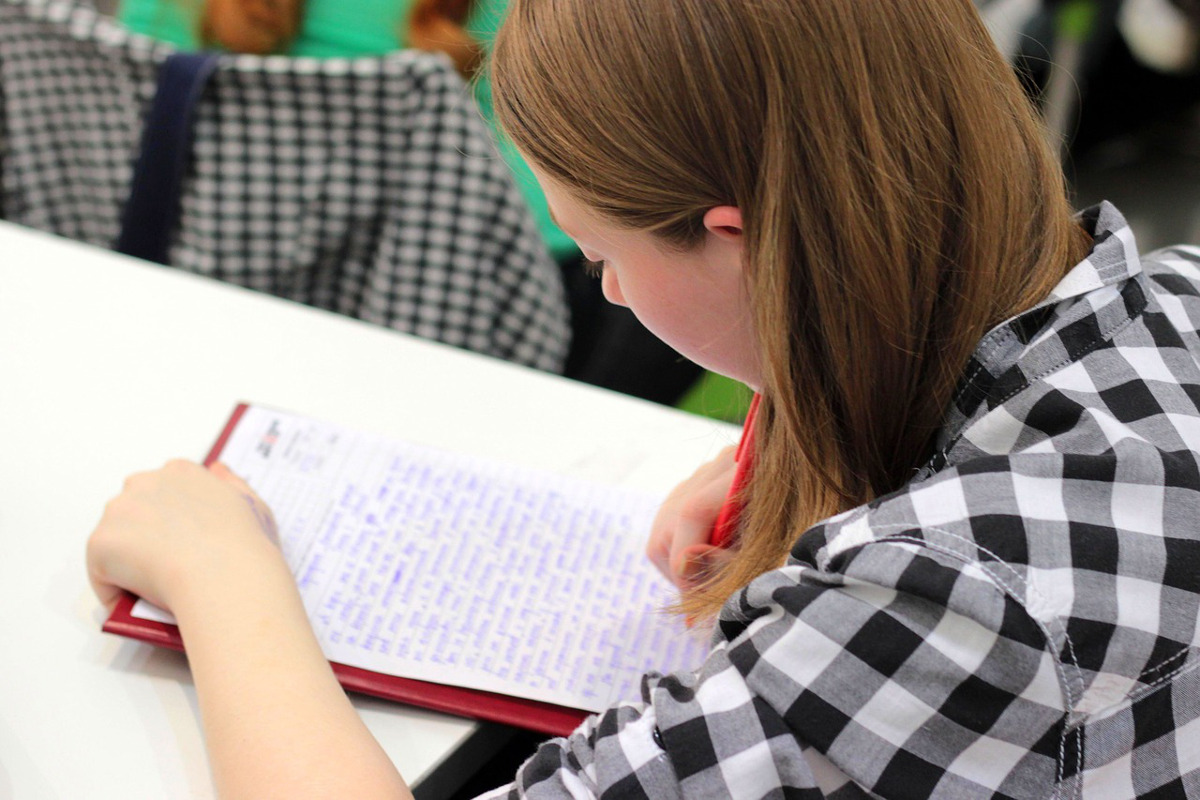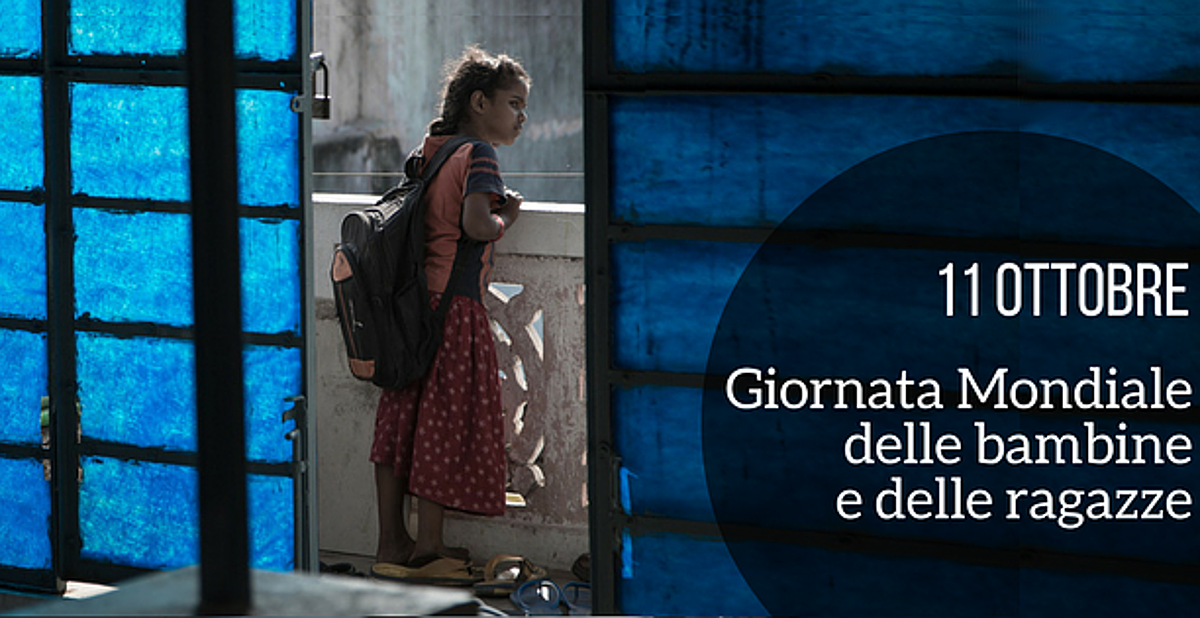Una misura mai applicata in Italia, la no tax area, e tre provvedimenti complementari in grado di allargare la risposta a diverse sfaccettature dello stesso bisogno, il diritto allo studio universitario. Una sorta di tavolo con quattro gambe: tutte insieme garantiscono l’equilibrio, se ne viene a mancare una, il tavolo si ribalta. Il tavolo, nel mio immaginario, è il dettato dell’articolo 34 della Costituzione, laddove dice che “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Le quattro gambe sono i provvedimenti contenuti nella legge di bilancio appena presentata dal Governo. In quelle quattro gambe c’è molto del mio lavoro, ma anche di quello di tutti i colleghi del Pd e delle altre forze politiche che, in questi anni, si sono interessati al diritto allo studio. Nel luglio scorso, alla Camera è stata approvata una mozione a mia prima firma sull’accesso all’università, promossa anche a fronte degli sconfortanti dati circa le percentuali di immatricolati e di laureati del nostro Paese. Quella mozione impegnava il Governo anche sul tema del diritto allo studio, in particolare a introdurre una no tax area e a stabilizzare i 50 milioni di euro aggiuntivi stanziati nel 2016 per il Fondo statale integrativo per le borse di studio che si aggiunge ai fondi disponibili presso le regioni. E, in effetti, nella Legge di Bilancio questi provvedimenti sono stati recepiti, insieme ad altre misure altrettanto positive. Trovo, quindi, francamente ingenerose alcune delle critiche che, subito, pur con accenti diversi, si sono levate. E’ vero che c’è sempre spazio per auspicare di più e di meglio, ma, per la prima volta in Italia, il tema del diritto allo studio è affrontato in modo sistemico e strutturale, per garantire una progressiva gradazione di interventi capaci di intercettare bisogni anche molto diversi. Perché, come disse Don Milani “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”: una lezione aggiornata da Ermanno Gorrieri nella sua riflessione su povertà, diseguaglianza e politiche redistributive.
Dobbiamo partire da tre dati di realtà.
Il primo è che mentre la strategia Europa 2020 della Comunità Europea fa perno su istruzione, ricerca/innovazione e società digitale per una “crescita intelligente” (in particolare attraverso il miglioramento dei livelli di istruzione e formazione) come miglior motore di sviluppo sociale ed economico, l’Ocse nell’ultimo rapporto Education at a Glance 2016 certifica che l’Italia è fanalino di coda per numero di laureati sulla popolazione in tutte le fasce d’età, compresi i 25-34enni.

Il secondo dato di realtà riguarda la regressività che, in generale, contraddistingue le tasse universitarie: vale a dire, concretamente, che il loro impatto percentuale decresce all’aumentare del reddito/patrimonio familiare dello studente, cioè le famiglie meno abbienti versano all’università uno quota dei loro reddito/patrimonio maggiore di quella pagata dalle famiglie più abbienti. Eppure la legge vigente (D.P.R. 25 luglio 1997, n.306, articolo 3) dispone che le università debbano graduare i contributi universitari “secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto”, per “garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica”, con l’unico limite (all’articolo 5) di un meccanismo che limita solo l’ammontare complessivo delle contribuzioni degli studenti in corso per ogni ateneo (che non può superare il 20% del finanziamento statale trasferito all’ateneo stesso). Invece, se si analizzano i diversi regolamenti universitari sulla contribuzione studentesca ci si rende facilmente conto di quanto pochi siano gli atenei statali che ottemperano davvero alla legge: poiché si tratta di una ricerca lunga e affatto facile (posso affermarlo avendolo sperimentato personalmente), consiglio almeno la lettura della scheda di sintesi “Equità orizzontale e verticale nelle tasse universitarie dei grandi atenei italiani” di Carlo Fiorio, Vito Peragine e Francesco Scervini, del Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016 (pp 349-352). Nonostante qualche imprecisione sui dati, in particolare per l’Università di Bologna che, contrariamente a quanto riportato, ha, al netto delle esenzioni dovute per legge o di interventi in situazioni molto particolari di alcuni studenti, una tassazione totalmente “piatta”, cioè indipendente dal reddito, con decontribuzioni concesse solo per “merito” (cioè in base al numero di crediti acquisiti), i risultati della ricerca avvalorano quanto stiamo ripetendo da tempo. Scrivono infatti gli autori: “In conclusione, tranne poche eccezioni, l’ammontare delle tasse universitarie degli atenei considerati appare essere prevalentemente regressivo: lo sforzo economico che le famiglie devono sostenere per l’istruzione universitaria dei propri figli è relativamente minore all’aumentare del patrimonio familiare”. Tutta responsabilità degli atenei e della insensibilità sociale dei Consigli di amministrazione? No, la questione è più complessa. Non si può dimenticare, innanzitutto, che dal 2009 al 2014 i finanziamenti statali per il funzionamento ordinario delle università sono calati continuamente, così che gli atenei hanno fatto fronte ai bisogni correnti con finanziamenti “esterni”, incluse le tassazioni studentesche, che per molte famiglie di ceto basso e medio, complice la crisi economica, sono diventate insostenibili. Risultato: dal 2003 al 2015 le università hanno perso, nel complesso, quasi 70 mila matricole, circa il 20% del totale. Di fronte a questa crisi delle immatricolazioni, che ha colpito tutti gli atenei, sia pure in modo differenziato perché alcuni, stante la reputazione didattica e scientifica raggiunta hanno continuativamente un bacino assicurato di studenti, alcuni atenei hanno reagito negli ultimi 2 anni con politiche “sociali” sul fronte dei contributi studenteschi: rammentiamo le esperienze pionieristiche di una sorta di no tax area introdotte dalle università di Firenze, Pisa, Palermo, Bari, Torino e altre ancora. Sono esperienze importanti, ognuna da studiare attentamente per gli esiti sui bilanci e sulle immatricolazioni: ma sono ancora poche per determinare una inversione di tendenza (che, lo so, deve essere sostenuta anche con interventi sulla qualità della didattica, ma questo è argomento che affronteremo in altra sede).
Il terzo dato di realtà riguarda il “tradizionale” sistema di diritto allo studio universitario (DSU), che per studenti in condizioni di basso reddito e di alto merito (almeno 25 crediti universitari il primo anno, 80 nel secondo e 135 nel terzo) prevede una borsa di studio, di importo fino a 5mila euro annui per i fuori sede. Il sistema però soffre di una gracilità strutturale dovuta sia alla cronica carenza di risorse, tale per cui molti ragazzi che soddisfano le condizioni di reddito e di merito richieste non ottengono la borsa (risultano “idonei” non viene garantito loro nient’altro oltre allo sgravio delle tasse), sia alle differenze profonde tra le varie regioni d’Italia, che hanno potestà legislativa in materia. Di fatto, non esiste un sistema nazionale di diritto allo studio, ce ne sono venti. La diversa sensibilità politica delle regioni fa la differenza (ci sono regioni, come l’Emilia-Romagna, ma non solo, che riescono a dare la borsa a tutti gli aventi titoli, grazie anche a risorse proprie, mentre in altre non si raggiunge il 20% degli idonei) ma questo impedisce la medesima esigibilità di uno stesso diritto su tutto il territorio nazionale.
Come interviene la legge di Bilancio su questi duri dati di realtà?
Innanzitutto con l’istituzione, in tutte le università statali, di una vera “no tax area” (cioè zero contributi universitari di qualunque tipo) per quegli studenti che hanno un reddito/patrimonio familiare (misurato con l’Isee) inferiore ai 13mila euro euro e che sono in ritardo al massimo di un anno sulla durata legale del corso di studio. Ecco la prima gamba del tavolo sopra-citato, una misura che aiuta e incoraggia chi vuole, comunque, cimentarsi con la formazione universitaria, sebbene le condizioni economiche di partenza non glielo consentirebbero. Non sono richiesti brillanti risultati scolastici pregressi, ma la dimostrazione di aver assunto con serietà il percorso formativo conseguendo almeno 10 crediti formativi su 60 entro agosto del primo anno e poi almeno 25 ogni 12 mesi successivi. Tasse calmierate sono poi previste per gli studenti che hanno un Isee familiare che va dai 13mila ai 30mila euro. Agli atenei sono garantite risorse compensative delle minori entrate, affinché possano continuare ad assicurare lo stesso livello dei servizi e della didattica. L’istituzione della “no tax area” è una innovazione sociale e culturale molto importante, che ci proietta in Europa, dove la gratuità o semi-gratuità dell’università è presente in molti Paesi.
Seconda gamba del tavolo: l’attività di tutoraggio. Analisi recenti dimostrano come ostacolo al proseguimento degli studi non è solo l’ambiente economicamente svantaggiato, ma anche un contesto culturale meno favorevole: è più probabile che concluda con successo il percorso universitario il figlio di due genitori laureati o comunque con diploma di scuola secondaria, con a disposizione libreria e computer casalinghi e un percorso di studi liceale alle spalle. Infatti, il Rapporto ANVUR 2016, già citato, conferma la relazione tra la provenienza scolastica e l’esito dei percorsi di studio universitari: il 32% degli immatricolati ex liceali risulta laureato nei tempi previsti a fronte del 19,1% di diplomati tecnici e solo il 16,2% dei diplomati professionali. Preoccupante, poi, è “l’altissima percentuale di studenti provenienti da un istituto tecnico o professionale che dopo 3 anni di corso ha abbandonato l’università (tra il 39% e il 46% contro il 16% dei liceali)” (p. 126 del Rapporto). Che fare, quindi, a fronte delle eventuali difficoltà che possono incontrare i giovani che provengono da un percorso di studi meno proiettato alla tradizionale formazione teorica, tipica dei licei? Oltre che ipotizzare percorsi di formazione superiore, anche universitari, con una curvatura maggiore verso la professionalità e il tirocinio – ma l’ipotesi esula dai contenuti tradizionali tipici di una legge di bilancio – va garantito un supporto adeguato di tutoraggio che, soprattutto nel primo anno, o in momenti di crisi, possa accompagnare lo studente a superare con profitto gli esami e quindi a conseguire la laurea.
Terza gamba, e terzo caso di bisogno, vale a dire i ragazzi che sono idonei al DSU ma, per carenza di risorse, non sono beneficiari di borsa di studio ma solo di esenzione dalle tasse (una sorta di DSU debole). Alla carenza di risorse si risponde rendendo stabile nel tempo l’incremento di 50 milioni già disposto per il 2016, così che il Fondo statale che integra le (poche) risorse regionali sarà definitivamente superiore a 210 milioni di euro. Il superamento del tetto di cristallo (200 milioni) era avvenuto occasionalmente solo nel 2009 e nel 2016: ora si dà certezza alle risorse e alle regioni, che potranno programmare meglio i propri interventi. Per dare poi maggiore equità alle modalità di riparto del Fondo tra le regioni, nella legge di bilancio si fa espresso riferimento ad un criterio di proporzionalità rispetto al fabbisogno finanziario di ciascuna regione.
Infine, la quarta gamba, che prende in considerazione ancora altri casi, quelli di giovani, sempre provenienti dalle classi sociali meno abbienti, che abbiano evidenziato negli ultimi anni delle scuole medie superiori talenti o meriti scolastici eccezionali. In questo caso, per almeno 400 di loro, è prevista una “superborsa di studio”, in grado di garantire allo studente non solo di iscriversi all’università e di acquistare libri e strumenti necessari allo studio, ma anche di affrontare, senza pesare economicamente sulla propria famiglia, una vita universitaria (o presso un Conservatorio o un’Accademia di Belle Arti) “in autonomia”, anche in una città diversa e lontana da quella di residenza. A fronte delle particolari attitudini – che vanno confermate nel corso degli studi universitari con requisiti di merito particolarmente elevati – questi giovani riceveranno dallo Stato una borsa di studio che consentirà loro di portare a termine il loro progetto formativo e di vita.
Con lo StudentAct, quindi, si prevedono risorse e misure mai sperimentate nel nostro Paese. Non ci sono solo soldi in più, è un vero cambiamento di prospettiva, che mantiene però il baricentro sull’equità dell’articolo 34 della Costituzione. A chi dice che sono norme che privilegiano alcuni, a scapito di tanti altri, rispondo che siamo lontani dalla retorica della meritocrazia sbandierata da Gelmini e Berlusconi: sono individuati criteri specifici e selettivi basati su precise condizioni sociali e anche, ma non solo, di merito, in quell’accezione costituzionale che tiene a mente le pari opportunità. E badate che dalla “no tax area” – una volta istituita – non si può tornare indietro. E’ una conquista di carattere sociale mai applicata in Italia, dove, lo abbiamo visto, l’università costa molto per i redditi più bassi. Altre misure, mutuate dall’estero e fino a pochi anni fa molto in voga, hanno avuto scarsissimi risultati: penso, ad esempio, al prestito d’onore sperimentato in Piemonte e sostanzialmente fallito. Se una famiglia non ce la fa a sbarcare il lunario, non si indebita per mandare un figlio all’università. Di queste misure altamente innovative andranno attentamente monitorati, nel corso dei prossimi anni, i risultati operativi e ne dovranno essere corrette le eventuali debolezze. Ciò nulla toglie al fatto che siamo di fronte a un cambio di paradigma, che non esito a definire “rivoluzionario”.
Salva
Salva
Salva